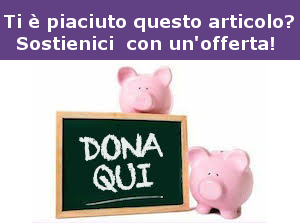Da Picnic a Hanging Rock a Master and Commander, passando per The Truman Show, i film di Peter Weir rappresentano una fuga dalla civiltà.
Una sagoma che poggia la sua mano su un volto addormentato trasmesso da un maxischermo. E, a sua volta, trasmesso sugli schermi di tutto il mondo a circuito continuo. Partendo da una struttura che, come la Grande Muraglia, è possibile vedere dallo spazio. Un allestimento faraonico per lo show più faraonico di tutti. La vita di un uomo dai suoi primi attimi agli ultimi. E in mezzo, l’infanzia, la crescita, la creazione di una famiglia, i saluti ai vicini e i pranzi della domenica. Una vita tranquilla e perfetta come quella che si sogna da sempre. Fino alla scoperta, casuale e senza importanza.

Una pagliuzza insignificante che, piano piano, diventa un fascio sempre più grande fino a diventare ingombrante. Non è più solo un sospetto. Ma qualcosa di più, la consapevolezza. E con lei il desiderio, finora rimasto sopito, di scoprire il mondo. Andare al di là del proprio giardino curato. Allontanarsi dalla comfort zone in cerca di qualcosa di diverso, magari non piacevole. Ma vivo e reale. Senza nessun occhio che spia avidamente ogni tua mossa.

Il volto di Jim Carrey addormentato su tutti gli schermi di The Truman Show (1998) è forse una delle immagini più importanti del cinema della fine del secolo scorso. In un periodo in cui la fantascienza iniziava, con una preoccupazione sempre maggiore, a raccontare l’invadenza delle nuove tecnologie. O di quelle che oggi definiremmo intelligenze artificiali. Un processo di progressivo allontanamento dalla realtà e anche dal concetto stesso di realtà. Come nei racconti di Philip K. Dick (1928 – 1982) in cui i personaggi, pur vivendo in una realtà futuristica apparentemente perfetta, sono completamente alienati. E anelano sempre al terreno, al mondo di secoli prima (ma che per noi è il presente più o meno immediato) perché privo di infrastrutture e di intelligenze altre divenute fin troppo presenti.
Eden – La lotta per la sopravvivenza apre il 42° Torino Film Festival
Un anno dopo The Truman Show, anche Ron Howard aveva raccontato la spettacolarizzazione della vita quotidiana fra alti e bassi, con Ed TV (1999). Ma lì si era arrivati allo show consapevole, alla messa in piazza coatta. Con The Truman Show, Peter Weir, invece, ha voluto narrare la parabola di un’anima inconsapevole e innocente dentro dei meccanismi che non è in grado di comprendere. Perché non ne ha mai posseduti realmente altri. È il dramma di Truman Burbank, Jim Carrey “l’uomo dalla faccia di gomma”, che involontariamente indossa una maschera e non vede quello che ha attorno.
Non capisce quando moglie, amici o conoscenti, si fermano a magnificare un prodotto, in una pubblicità occulta dietro l’altra all’interno di un ennesimo Sogno Americano. Un Tempo del Sogno, lontano da quello a cui gli aborigeni della natia Australia di Weir ambiscono tornare. Dall’American Dream bisogna fuggire per risvegliarsi.
Furiosa: A Mad Max Saga – Da Cannes torna l’universo di George Miller
Peter Weir, classe 1944, è stato recentemente premiato con il Leone d’Oro alla Carriera all’81 Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Il suo cinema è costellato dal sogno. Nella sua fuga verso esso o da esso. Lontano dai costrutti, pronti ad essere travolti sotto un nuovo diluvio. Come quello de L’ultima onda (1979), ambientato in un mondo in cui alte maree, piogge torrenziali e grandine nel mezzo del deserto sono la premessa verso il cambiamento. Segnano la fine di un ciclo e l’inizio di un altro. L’arrivo di un nuovissimo mondo più scintillante. In esso si potrebbe ricominciare con una saggezza più antica e assennata. E questo passaggio è simboleggiato dall’acqua che precipita, scorre o si espande ovunque come a voler ripulire via tutto.
Oppure come un punto di contatto fra un mondo e l’altro. La porta per il Tempo del Sogno nel film del 1979 si trova nelle profondità di Sydney, nel cuore della metropoli dove le antiche leggi tribali forse non valgono più nulla. Una discesa costante che porta fino al mare al tramonto di una civiltà e il principio di un’altra.
Proprio oltre il mare si trova quello che cerca Truman. Lo vuole raggiungere con una barchetta da pesca, ostacolata da tempeste, e venti al limite del sopportabile. Il mare diviene la vera transizione. Nelle sue distese si muovono i marinai inglesi in epoca napoleonica di Master and Commander – Sfida ai confini del mare (2003).
Durante la caccia di una fregata francese nella calma piatta dell’Oceano Pacifico, il comandante Aubrey (Russell Crowe) e il medico di bordo Maturin (Paul Bettany), suonano e discutono in cabina. Del dovere a cui l’uomo deve obbedire perché una società gerarchica possa rimanere inalterata. A confronto con la primitiva semplicità della vita naturale, degli insetti e delle creature primordiali che popolano le isole Galapagos. Una delle tappe del viaggio nel quale, fra le distese vulcaniche che sanno di un tempo prima del tempo, si avventura Maturin, prima ancora di Darwin. Un mondo diverso e dal quale si vorrebbe costantemente tornare perché visceralmente affascinati e colpiti.

Si tratta della contrapposizione fra la cultura e la scienza naturale, più vicina alla Natura stessa nella quale gli aborigeni de L’ultima onda si perdevano. Alimentando domande che non hanno che risposte vaghe. Le stesse che si pongono i protagonisti, di fronte alla formazione vulcanica dove scompaiono tre fanciulle vittoriane in Picnic a Hanging Rock (1975). Quest’ultimo presentato restaurato dalla Cineteca di Bologna dal 3 Febbraio in occasione del cinquantenario dell’uscita. Si tratta del racconto di un Altrove del quale non si ha memoria ma che è facile raggiungere. I confini non sono quelli disegnati su di una mappa. Quelli di un mondo esterno, la Terra Ignota che Truman vuole esplorare. Non senza aver prima dato il suo saluto a chi rimane: «Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!».