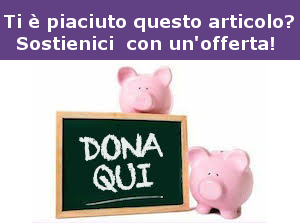Scienziati del clima, da Tyndall a Newton Foote, da Arrhenius a Crutzen, un breve excursus negli scienziati che hanno contribuito a scoprire cambiamento climatico e riscaldamento globale
George-Louis Leclerc. Antonio Stoppani. Svante Arrhenius. Mario Molina. Eunice Newton Foote. Paul Crutzen. John Tyndall. Se state leggendo eHabitat è perché vi interessate di questioni legate all’ambiente, quindi la domanda che vi poniamo è la seguente: quanti scienziati conoscete fra i sette che vi abbiamo proposto?
È emergenza climatica: 11mila scienziati lanciano l’allarme proponendo sei misure urgenti
Ora facciamo una controprova con altri sette nomi. Guglielmo Marconi. Thomas Edison. James Watt. Karl Benz. Nikola Tesla. Marie Curie. Tim Berners-Lee. Quanti ne conoscete? Se non c’è partita fra la popolarità dei sette personaggi del primo gruppo e quella del secondo, lo si deve molto probabilmente al fatto che le scoperte dei primi sono legate al clima, quindi a un impalpabile “iperoggetto”, mentre quelle dei secondi hanno portato un progresso concreto e commercialmente spendibile nel mondo della scienza e della tecnica. In altre parole i primi ci hanno chiesto di rallentare, i secondi ci hanno dato gli strumenti per accelerare. La storia, si sa, la scrivono i vincitori ed è indubbio che a questa regola non si sottraggano gli eroi di un mondo in cui tecnica è sinonimo di progresso e di sviluppo.
Le scoperte compiute dai primi sette scienziati che vi abbiamo nominato, però, hanno avuto, hanno e avranno un’importanza capitale per i destini del Pianeta in cui viviamo. Se vogliamo continuare nel gioco del dualismo potremmo dire che, in alcuni casi, i primi hanno fatto delle scoperte che hanno consentito di rimediare ai danni fatti involontariamente dai secondi, in quel braccio di ferro fra salute e lavoro che è la storia dell’umanità, dalla Rivoluzione Industriale a oggi.

Nel 1778, George-Louis Leclerc, conte di Buffon, in uno dei 36 volumi della sua Histoire Naturelle sottolinea come l’uomo alteri la temperatura e le precipitazioni, attraverso la modificazione della vegetazione e la combustione del carbone. Siamo all’alba della Rivoluzione Industriale e al crepuscolo dell’Ancien Régime, ma Leclerc ha già capito che l’attività umana è in grado di alterare il clima. Novant’anni dopo, il geologo e paleontologo Antonio Stoppani propone la definizione di “epoca antropozoica”; nella sua opera in tre volumi Note scrive: “la creazione dell’uomo è l’introduzione di un elemento nuovo nella natura, di una forza affatto sconosciuta ai mondi antichi”, di fatto un’idea che precorre quella di Antropocene proposta da Paul Crutzen nel 2000. Scomparso lo scorso 28 gennaio, Crutzen non è noto soltanto per avere proposto una nuova denominazione per l’era geologica attualmente in corso, ma, insieme a Mario Molina e Frank Sherwood Rowland, ha contribuito a lanciare l’allarme in merito alla concentrazione di cluorofluorocarburi sullo strato di ozono dell’atmosfera. Nel 1995 questi tre ricercatori hanno conseguito il Premio Nobel per la Chimica e il Protocollo di Montréal, adottato nel 1987 per ridurre il buco dell’ozono, è stato il primo trattato universale a produrre effetti benefici su scala globale.

L’effetto serra ovvero il fenomeno alla base del riscaldamento globale è una scoperta di ben duecento anni fa, il primo a renderne ufficiale l’esistenza fu il fisico francese Joseph Fourier, il quale comprese che l’atmosfera rinviava, in modo naturale, una parte dei raggi solari verso la Terra. Agli studi compiuti negli anni Venti dell’Ottocento da Fourier, aggiunse un tassello importante il fisico irlandese John Tyndall che nel 1861 scoprì come i gas all’origine di questo fenomeno fossero il vapore acqueo (H2O) e il diossido di carbonio (CO2). Soltanto più tardi, altri studiosi identificarono altri gas responsabili dell’effetto serra, come il metano e l’esafluoruro di zolfo.
Nel 1856, un altro importante tassello nella comprensione dell’effetto serra venne dagli studi della scienziata statunitense Eunice Newton Foote, la prima scienziata a sperimentare l’effetto di riscaldamento della luce solare sui diversi gas e a teorizzare che l’alterazione della proporzione di anidride carbonica ne avrebbe modificato la temperatura. Nel 1896 il chimico svedese Sven Arrhenius formulò la prima legge dell’effetto serra, secondo la quale a una progressione geometrica della quantità di diossido di carbonio immessa nell’atmosfera segue una progressione aritmetica della temperatura terrestre.
Umberto Monterin, un libro racconta il pioniere della climatologia storica
Di Umberto Monterin, lo scienziato alpinista che nella Valle d’Aosta del primo Novecento studiò il fenomeno dello scioglimento dei ghiacciai, vi abbiamo già parlato in passato, mentre non si può non citare lo statunitense Charles David Keeling, che, grazie alle misurazioni compiute nell’Osservatorio di Mauna Loa, ha allertato per la prima volta il mondo sul contributo antropogenico all’effetto serra e al riscaldamento globale. Il grafico che mostra il progressivo aumento del gas serra e che stiamo vedendo sempre più spesso negli ultimi anni è detto Curva di Keeling.
È solo questione di tempo: questi scienziati conosciuti soltanto nel mondo accademico o fra gli addetti ai lavori ci hanno dato gli strumenti per decrittare fenomeni che giocano un ruolo determinante nella vita, umana e non umana, del Pianeta, in un futuro prossimo probabilmente impareremo a conoscere i loro nomi e quanto è stato prezioso il loro lavoro.
[Foto Wikipedia di Biswarup Ganguly – Opera propria, CC BY-SA 3.0 e pubblico dominio – Pixabay]