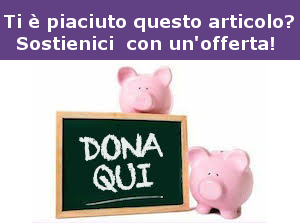Il cielo notturno di novembre è illuminato da un’affascinante forestiera, che si reca in visita al pianeta Terra all’incirca ogni 2.500 anni. Stiamo parlando della cometa Erasmus (C/2020 S3) e per assaporare lo spettacolo della sua chioma verde vale la pena puntare la sveglia qualche ora in anticipo uno dei prossimi giorni. Un appuntamento immancabile per gli astrofili che quest’anno sono già stati deliziati dal passaggio di varie comete e che si stanno preparando all’eclissi lunare di penombra del 30 novembre.
Come vedere la cometa Erasmus
La cometa Erasmus sarà visibile poco prima dell’alba fino alla fine di novembre. Intorno alle 5.30 del mattino, quando l’oscurità non ha ancora lasciato spazio ai primi raggi di Sole, è sufficiente volgersi a sud-est, meglio se armati di un binocolo. La cometa si trova appena a destra di Venere, pianeta che può essere usato come guida: è il corpo celeste più brillante all’alba. In assenza di nubi e inquinamento luminoso Erasmus dovrebbe essere ben identificabile, anche perché nell’avvicinarsi al Sole sta diventando sempre più vivida.
Il viaggio nello spazio del corpo celeste
Nel suo veleggiare verso il cuore del Sistema Solare, Erasmus raggiungerà il perielio – ovvero la massima vicinanza al Sole – il 12 dicembre. Si troverà allora nell’orbita di Mercurio, e da lì invertirà nettamente la rotta per proseguire il suo viaggio solitario. Secondo le stime del JPL’s Solar System Dynamics della NASA, la cometa Erasmus ha un periodo orbitale di 2.512 anni. Per la stragrande parte del tempo la sua orbita attraversa il freddo spazio lontano dal Sistema Solare: ecco perché Erasmus sarà nuovamente visibile dal nostro pianeta solo tra un paio di millenni.
Tauridi, lo sciame meteoritico arriva nei cieli d’autunno
La scoperta della cometa Erasmus
La cometa Erasmus ha probabilmente avuto origine nella Nube di Oort, una nube sferica di detriti ai confini del Sistema Solare. Come ogni cometa, questo corpo di rocce, ghiaccio e sostanze gassose congelate deve la sua “chioma” alla vaporizzazione dei materiali che ne compongono il nucleo nel momento in cui si avvicina al Sole. Il suo nome deriva invece dal suo scopritore Nicolas Erasmus, il primo a identificarla nei cieli delle Hawaii lo scorso 17 settembre.